Papa Urbano VIII

Notizie: (Firenze, 5 aprile 1568 - Roma, 29 luglio 1644) Urbano VIII, nato Maffeo Barberini fu il 235esimo papa della Chiesa cattolica dal 1623 alla morte. Maffeo Barberini era il quinto dei sei figli di un ricco mercante fiorentino della famiglia Barberini. Come molti rampolli di famiglie doviziose, studiò presso i gesuiti prima, e presso il Collegio Romano poi. Trasferitosi a Pisa, conseguì la laurea in giurisprudenza, così come era desiderio della famiglia. A soli venti anni entrò, come avvocato, nell'amministrazione dello Stato Pontificio ove svolse una lunga e prestigiosa carriera, coronata anche dall'incarico di Nunzio apostolico a Parigi. Dal 1604 al 1608 fu arcivescovo di Nazareth, Canne e Monteverde, con sede a Barletta in Puglia. In questo periodo, all'età di 38 anni (ovvero nel 1606), ricevette la berretta cardinalizia da papa Paolo V, che gli fu imposta dalle mani di Enrico IV, re di Francia. Due anni più tardi, lasciò la sede nazarena e divenne vescovo di Spoleto. Morto lo zio che, da giovane, lo aveva ospitato a Roma, ne ereditò il cospicuo patrimonio, con il quale acquistò un prestigioso palazzo, arredandolo in maniera estremamente sfarzosa, sullo stile rinascimentale, lussuoso a tal punto da diventare il personaggio più in vista e importante della città. Il suo atteggiamento neutrale gli fu di aiuto per la sua elezione. Il pontificato: il pontificato del Barberini si aprì quando la Guerra dei trent'anni era in pieno svolgimento. Le operazioni belliche erano, infatti, già iniziate da ben cinque anni e si stava per concludere il cosiddetto "periodo boemo - palatino" con la sconfitta dei protestanti, la vittoria degli imperiali e l'esilio di Federico V, principe elettore del Palatinato. Stava anche per iniziare il "periodo danese" che vedeva uno schieramento di alleanze alquanto diverso da quello che aveva caratterizzato il precedente arco di tempo. La Francia, infatti, non era più nelle mani della reggente Maria de' Medici, ma in quelle del potente cardinale Richelieu, primo ministro di Luigi XIII. Il Richelieu, pur cattolico, non intendeva più appoggiare il cattolicissimo Impero asburgico, onde evitare un nuovo accerchiamento come ai tempi dell'Imperatore Carlo V. Facendo, quindi, prevalere la ragion di stato, si schierò dalla parte dell'alleanza tra l'Inghilterra, l'Olanda e la Danimarca, in funzione antiasburgica. La qual cosa significava l'appoggio della Francia ai prìncipi luterani, con la conseguenza della fine di ogni possibilità di restaurazione cattolica in Europa. Urbano VIII, ritenendo che la guerra in Europa si combattesse ancora per fini di religione, si era schierato con la Francia, ancor prima che il Richelieu decidesse di schierarsi contro l'Impero. Questo errore di valutazione politica e strategica ebbe come conseguenza la perdita di credibilità della figura del Papa come arbitro delle controversie internazionali. L'errore fondamentale del Barberini stava nel fatto che, invece di proporsi come arbitro delle controversie religiose, egli tentò di proporsi come arbitro delle controversie politiche tra gli Stati in lotta, autoproclamandosi, in tal modo, egli stesso come uno Stato al di sopra degli Stati. Non si era reso conto che lo Stato Pontificio, con lo scoppio della guerra dei trent'anni, ormai contava ben poco. Nel 1627 con la costituzione apostolica Debitum istituì la Congregazione dei Confini per provvedere alla difesa dello Stato Ecclesiastico, impedendo ogni cessione illegale, risolvendo ogni vertenza giurisdizionale interna o con gli stati esteri limitrofi e cercando di riacquisire i territori perduti. Una vicenda alquanto sensazionale lo vide impegnato nella impresa della riconquista del ducato di Castro e Ronciglione, che in quel momento era nelle mani di Odoardo I Farnese. Il ducato di Castro, ubicato alle porte di Roma, era stato assegnato da papa Paolo III (Alessandro Farnese) ai nipoti, unitamente a notevoli privilegi fiscali. Ma Urbano VIII veniva da una famiglia rivale della famiglia Farnese, e nello stesso tempo intendeva riportare il ducato sotto il governo dello Stato della Chiesa. Approfittando del fatto che i Farnese in quel momento erano fortemente indebitati presso alcuni banchieri romani, il Papa confiscò tutti i loro beni e dichiarò loro guerra. Il ducato di Castro fu occupato nel mese di ottobre del 1641; successivamente Odoardo Farnese fu scomunicato e il Pontefice lo dichiarò decaduto da tutti i diritti di proprietà e sovranità, minacciandolo di privarlo anche del ducato di Parma e Piacenza. Fallito ogni tentativo di giungere ad un accordo, il Papa dichiarò che il ducato di Castro era possedimento della Chiesa e la famiglia Farnese ne aveva usurpato il titolo. L'atteggiamento del Papa su questa vicenda, però, indusse gli altri principi italiani a guardare con sospetto la posizione del Pontefice. Costui, infatti, se fosse venuto in possesso anche del ducato di Parma e Piacenza, avrebbe costituito una potenziale minaccia all'integrità territoriale degli Stati dell'Italia del Nord, soprattutto perché Urbano VIII era appoggiato dalle armi francesi. Odoardo Farnese, presa coscienza di avere l'appoggio di tutte le signorie dell'Italia del Nord, e ottenuta l'alleanza di Firenze e Venezia, allestì un piccolo esercito, alla testa del quale marciò verso Roma, dando inizio ad una vera e propria guerra che andò avanti, con alterna fortuna, per ben quattro anni. Le operazioni militari ebbero termine soltanto a causa dell'esaurimento delle finanze da parte di tutti i belligeranti. Nel 1644 si raggiunse un accordo di pace che vide non solo la revoca della scomunica da parte del Papa, ma anche la restituzione del ducato di Castro al Farnese. Si era consumato, in tal modo, un altro fallimento della politica di Urbano VIII. Sul piano dei rapporti internazionali, come detto, il papato di Urbano VIII si svolse tutto in contemporanea alle vicende legate alla Guerra dei trent'anni, di cui il Pontefice non riuscì a vedere la conclusione. Affondò ulteriormente la frattura tra cattolici e protestanti schierandosi contro l'Impero, così che l'Imperatore Ferdinando II d'Asburgo, dopo aver firmato il ben noto "Editto di restituzione" mediante il quale restituiva alla Chiesa cattolica le sedi ecclesiastiche sottratte ai protestanti, iniziò a nominarne i vescovi, nonostante il netto rifiuto papale ad autorizzarlo in una tale pratica, del quale l'Imperatore non tenne alcun conto. L'autorità papale ne uscì umiliata e il Barberini non si oppose a questa decisione. Anche re Gustavo II Adolfo di Svezia, sebbene alleato del Papa contro l'Imperatore, si ribellò alle richieste papali rifiutandosi di consegnare al Pontefice i vescovadi sottratti ai protestanti nella Germania del Nord durante la guerra. Papa Urbano VIII si oppose blandamente al giansenismo proibendo ogni disquisizione sul tema della grazia e su quello del libero arbitrio, rinviando i contenuti a quanto aveva stabilito al riguardo il Concilio di Trento, ma non applicò mai condanne. Durante il suo pontificato, il Barberini attinse a mani basse nelle casse dello Stato, sia per favorire i suoi familiari cui concesse cospicue donazioni consentendo arricchimenti scandalosi e illeciti e sia per realizzare i numerosi interventi edilizi, civili e militari, che caratterizzarono il suo ventennio sulla cattedra di Pietro. Ciò comportò un dissanguamento delle finanze dello Stato che impose il ricorso a numerose ed elevate tassazioni esclusivamente verso il popolo, facendo salvi i privilegi della classe nobiliare e del clero. Il malcontento popolare crebbe a tal punto che il Papa dovette far ricorso ad interventi alternativi per accontentare i suoi sudditi, riesumando vecchie abitudini festaiole cadute in disuso da anni per effetto della Controriforma e dell'Inquisizione. Ripresero le pubbliche feste, la caccia e le rappresentazioni teatrali, con l'effetto di peggiorare la finanza dello Stato. Concesse persino al clero, al livello delle più alte cariche ecclesiastiche, di abbandonarsi ad atteggiamenti dissoluti e prodighi, pur di accattivarsene le simpatie. Urbano VIII fu del resto sospettato di aver un'amante e al tempo lo si accusò di esser cedevole alla lussuria, notizia poi non provata: nel 1634 fece allontanare da Roma un funzionario pontificio che pare avesse sorpreso il papa in comportamenti intimi con un bambino. Malgrado la rigida censura, fioccarono su di lui numerosissime Pasquinate. Durante il suo pontificato convocò otto concistori, nel corso dei quali procedette alla nomina di ben 74 cardinali. Tra essi figuravano Francesco Barberini e Antonio Barberini, rispettivamente nipote e fratello del Papa; Giovanni Battista Pamphili, Patriarca titolare di Antiochia che venne poi eletto Papa il 5 settembre 1644 col nome di Innocenzo X; Antonio Barberini, altro nipote del Papa; Lorenzo Magalotti, cognato del Papa; Ascanio Filomarino, Arcivescovo di Napoli; Marco Antonio Bragadin, Vescovo di Vicenza. Elevò agli onori degli altari molti santi, tra i quali ricordiamo Francesco Saverio, Filippo Neri, Luigi Gonzaga e Ignazio di Loyola; beatificò Maria Maddalena de' Pazzi. Galileo Galilei: il pontificato di Urbano VIII vide compiersi il processo a Galileo Galilei, quale sostenitore della teoria copernicana sul moto dei corpi celesti, in opposizione alla teoria aristotelica-tolemaica sostenuta dalla Chiesa. La vicenda era nata sotto il pontificato di Camillo Borghese, Papa Paolo V (1605-1621).
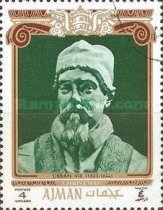
Stato: Ajman Data: 24/08/1971 Emissione: Natale 1971 Dentelli: 13½ x 13½ Filigrana: Senza filigrana Stampa: Fotoincisione |
|---|
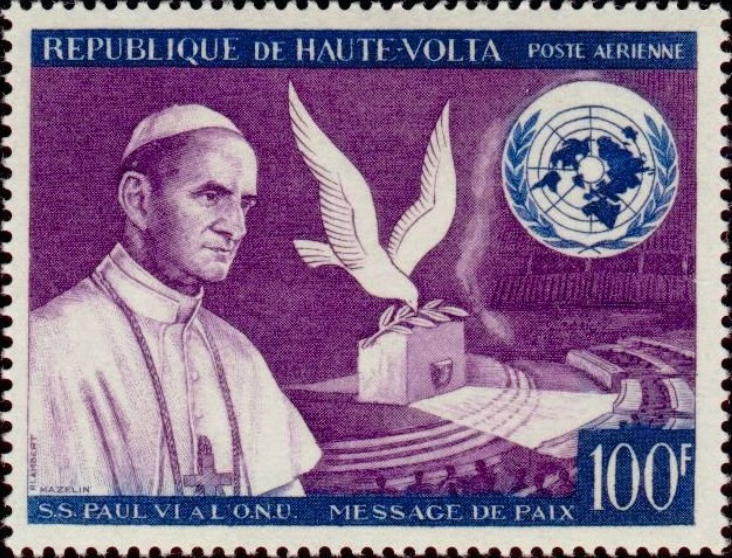
Stato: Upper Volta Data: 05/11/1966 Emissione: Visita di Paolo VI alle Nazioni Unite Dentelli: 13 x 13 Filigrana: Senza filigrana Stampa: Calcografia |
|---|
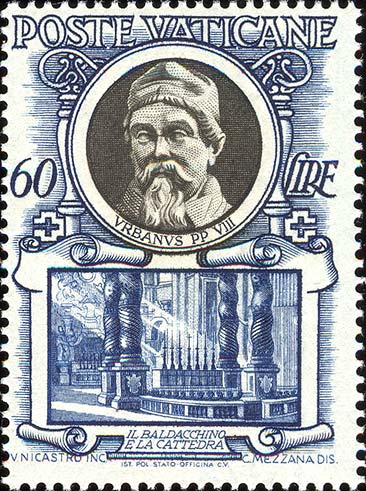
Stato: Vatican City Data: 23/04/1953 Emissione: Pontefici Dentelli: 13½ × 13¼ Tiratura: 450.000 Filigrana: Filigrana chiavi incrociate Stampa: Calcografia Bozzettista: C. Mezzana |
|---|

Stato: Vatican City Data: 23/03/1999 Emissione: I Papi e gli Anni Santi Dentelli: 13 Tiratura: 450.000 Stampa: Litografia |
|---|